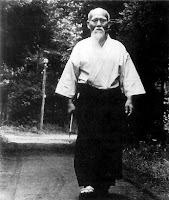Si tratta della complessa dinamica che accade quando un gruppo perde la sua guida.
Sono tante le ragioni per le quali un Maestro non possa più garantire ai proprio allievi la continuità che storicamente invece ha mantenuto: ci sono persone che vengono trasferite per lavoro in altre città, persone che smettono di voler insegnare per ragioni di tipo personale, altre persone si ammalano e la salute non consente loro di riprendere l'attività... altre che mancano proprio all'affetto dei loro cari e degli allievi stessi.
Molte di questi motivi sanno essere anche abbastanza improvvisi ed imprevedibili, perciò non è spesso possibile organizzare un distacco ed una riorganizzazione serena delle attività, designando qualcuno che possa farsene carico, una sorta di successione o avvicendamento naturale all'insegnamento.
È la vita: pochi sono quelli che la stravolgono o muoiono proprio quando vogliono loro...
Resta però un gruppo, un'insieme di persone - piccolo o grande fa poca differenza - che si riunivano intorno a chi non c'è più o non può più esserci: cosa fare in queste situazioni?
Una seconda volta sono stato coinvolto da una dinamica simile come Sensei... ma intorno al 1999 lo sono stato - per la prima volta - anche come allievo, quindi parlo con cognizione di causa e per esperienza personale.
Partiamo da qui: nel 1999 il mio Sensei di allora - tutt'oggi vivo e vegeto - per questioni personali aveva deciso (abbastanza all'improvviso) di abbandonare l'insegnamento: io all'epoca ero il senpai del gruppo, diventato shodan un paio di anni prima, non molto di più.Per molti versi, era già naturale per me dare una mano al mio Maestro sul tatami, ma non avevo alcuna ambizione imminente di diventare il responsabile o il referente del gruppo del quale facevo allora parte. Avevo 25 anni.
Una sera egli venne e, con uno strano rituale, mi disse che da quel momento in poi sarei stato io il Maestro, che non dovevamo più fare affidamento su di lui.
Non fu per nulla semplice ciò che avvenne da li in poi. Non accettare la cosa avrebbe significato lo scioglimento del gruppo nel quale ero cresciuto però, quindi provai ad andare avanti... con l'intenzione di salvare il salvabile.Quando ci si iscrive ad un corso, in prima istanza lo si fa perché si sente affinità con chi lo gestisce: quindi non è scontato che un avvicendamento alla direzione del Dojo sia compreso, accettato ed accolto favorevolmente da tutto il gruppo.
Quella fu la prima cosa che accadde, ma non l'unica visto che mi apprestavo a ricoprire un ruolo per il quale avevo molta meno competenza di chi mi aveva preceduto.
Il gruppo, già quindi "traumatizzato" dalla perdita della propria guida di riferimento, viene ulteriormente a zoppicare per la perdita di alcuni suoi membri storici. E siccome il gruppo medio in Aikido di solito non è composto di 30 persone, si fa presto a rimanere in 3 o 4.Noi rimanemmo in 7 all'epoca. Alcuni se ne andarono e ci venne pure notificato che da li a breve avremmo pure dovuto cercare una nuova sede per gli allenamenti, poiché la palestra che ci ospitava aveva intenzione di rimodulare l'utilizzo delle sue sale.
Se c'è un'altra piaga d'Egitto che si può abbattere su un gruppo di praticanti di Aikido è il cambiamento della SEDE degli allenamenti: questo non vuole solo dire vedersi allontanare (quasi sempre) o avvicinare (quasi mai) il Dojo a casa, ma anche vedersi cambiare giorni ed orari del keiko.
Il trasferimento di un gruppo potrei supporre che comporti all'incirca la perdita del 20-25% dei suoi membri, così su due ashi.
Bene, a me è successo questo ed anche di più, ma mi fermo qui per ora con il mio improvviso affaccio all'insegnamento. Posso solo dire che non fu facile e trovammo un nuovo equilibrio stabile solo dopo alcuni ANNI dal cambiamento di Sensei e di sede.
Veniamo a quando invece sono stato contattato in qualità di insegnante... per un Sensei che purtroppo era venuto a mancare.
Parliamo di Gianflilippo Rutigliano, e siamo nel 2015 (potete leggere QUI la sua storia). Dovete sapere che conobbi Filippo proprio grazie a queste pagine: lui mi contattò per complimentarsi di Aikime e dei suoi contenuti, mi disse di essere un fan di questo Blog e fu subito facile sentirci al telefono giacché entrambi al tempo vivevamo ed insegnavamo nella stessa città.Filippo da li a non molto però si ammalò gravemente ed uno dei suoi senpai - Gianfranco Colucci, il compagno di una cara amica della mia compagna - agevolò che io e Filippo ci incontrassimo.
Le cose non andarono bene per lui e purtroppo di li a non molto venne a mancare: il senpai non se la sentiva di farsi perennemente carico esclusivo del gruppo, così come aveva fatto durante il periodo di convalescenza del suo Maestro; mi chiese quindi se avessi potuto garantire una supervisione delle attività.
Lui, che era conosciuto da tutto il gruppo, teneva le lezioni regolari: il mio compito era dare una supervisione a lui ed un appoggio con il mio gruppo per eventi speciali e seminari. Mi occupavo già solo di Aikido al tempo, il mio gruppo era solido e florido e potevo garantire a questo gruppetto l'appartenenza ad una realtà viva e funzionante della nostra città.
Poco dopo essere partiti - ed aver notato che già non tutti avevano preso benissimo questo progetto - accadde purtroppo un incidente a questo senpai, che gli impediva anche di tenere le lezioni regolari del gruppo. Alcuni dei suoi membri iniziarono allora a frequentare il mio Dojo per non rimanere fermi, mentre inviai un docente del mio Dojo a dare man forte all'ex-gruppo di Filippo presso la loro sede... per tutti coloro che volevano continuare ad allenarsi la.Fu un semi disastro: alcuni (pochi) si integrarono da me o con il nuovo docente presso la loro sede storica, tutti gli altri (la maggioranza) si persero per la strada. Solo una persona continuò nella vecchia sede con il nuovo Insegnante (e continua tutt'ora per la cronaca!).
Come mai accadde questo?Ho alcune accreditare ipotesi...
Un allievo tende a cercare nel nuovo insegnante i tratti di quello vecchio che ora non è più li: però questi è un'altra persona, che ha un altro modo di fare... e soprattutto può avere una visione dell'Aikido anche differente.
Può essere differente anche l'approccio tecnico e metodologico per l'insegnamento: tutti fattori che creano spaesamento sia a chi aveva iniziato da poco e si vede cambiare tutto sotto gli occhi, perdendo anche quei pochi punti fermi che credeva di possedere...
... e sia a chi stava nel gruppo da più tempo, che non sempre - proprio in virtù della sua maggiore esperienza - è disposto di mettere in discussione le certezze che credeva di avere consolidato.Il nuovo inizio con una persona differente è - in ogni caso - complicato per tutti: sia perché è restato, che vede cambiare il "dialetto" Aikidoistico al quale era abituato... sia a chi arriva e prova a dare del proprio meglio, ma ben conscio di non potere, né volere essere il clone di chi non è più li ad insegnare.
Un mese fa è accaduta la stessa dinamica aggruppo del mio amico Pietro Anselmo Sensei (il cui addio potrete trovare QUI): ora giustamente si stanno interrogando... cosa fare? Continuare, non continuare?
Se continuare, come e con chi?
Domande più che legittime che richiedono maturità in un gruppo, o che lo costringono in ogni caso a maturare piuttosto in fretta...
Dall'esperienza diretta ed indiretta che ho maturato sull'argomento posso però anche affermare alcune cose: pin primis, per quanto sia traumatico, improvviso, sconvolgente ed indesiderato vedere scomparire la propria guida, ciò costringe a chiedersi quanto ciascuno ci tenga a proseguire con lo studio della disciplina o meno, ed a rimappare le propria disponibilità per consentirci di proseguire la strada.
In dietro non si può tornare, quindi se uno vuole andare avanti è indispensabile comprendere come, dove e - soprattutto - con chi ciò sarà possibile.E aggiungo che mediamente ogni praticante maturo è passato per almeno 2, 3, 4 momenti così nella propria carriera... quindi questo stop forzato può fare il distinguo fra quelli che si scoraggiano e rinunciano a proseguire, e quelli invece che continueranno in futuro a saper fare la differenza per se stessi e per gli altri.
Di solito da eventi di questo genere vengono forgiati buoni docenti futuri, quelli che appunto avranno avuto il coraggio di andare avanti.
In secondo luogo: sia i neofiti, che i senpai cresciuti sotto egida di una SOLA scuola ed insegnante specifici tendono ad ignorare che l'Aikido è composto da una moltitudine di visioni, didattiche e modalità tecniche/stilistiche differenti.
Questo "sentirsi a casa" fa stare bene, è rassicurante... ma è anche molto parziale e di nuovo, ogni praticante esperto sa che ciò che affermo è reale.
Lo stop improvviso legato al venire meno della priora guida quindi può divenire l'occasione d'oro per scoprire che c'è molto più Aikido fuori dal nostro piccolo recinto di quanto non si immagini, e questo sia se si decide di proseguire la strada a livello singolo, sia se si decide di chiamare un nuovo insegnate al posto di quello che non c'è più.
Di certo l'Aikido è sia una strada personale, che collettiva... quindi è possibile sia confluire in altri gruppi che ci sembrano sani (opzione che al momento mi pare più percorribile), sia studiare il modo per far sopravvivere il proprio gruppo (opzione possibile, ma più ostica nel concreto).
Un aspetto è certo: guai a cercare nella nuova configurazione tracce di quella vecchia... nella nuova guida l'ombra di quella vecchia!Ikkyo sarà sempre ikkyo e difficilmente si farà sulle orecchie, però acclimatarsi sotto la direzione di un nuovo Maestro richiede tempo (qualche anno?): giudicare quando il nostro vecchio percorso fosse meglio, peggio o analogamente qualitativo rispetto al percorso nuovo che abbiamo scelto (se ovviamente non abbiamo stato per mollare tutto) è qualcosa di intelligente, auspicabile... ma non da fare nei primi 3 mesi successivi al cambiamento.
Proprio no: dobbiamo darci tempo...
Poiché sarà un po' come cambiare nazione, lingua, usi e costumi: ci va più di un attimo a comprendere ciò che è comune nonostante le differenze... mentre queste sono le prime che ci si palesano di fronte e creano talvolta scomodità.
Nuovamente è necessaria una certa maturità per non spaventarsi e fuggire via, cercando di rifugiarsi mentalmente ed emotivamente nei ricordi di un passato che - per quanto bello - è destinato a non tornare più.
Ma, esattamente, quali sono le dinamiche che sono capaci di dare frutto e che non necessitano di un certo grado di maturità personale?! NESSUNA...
Il rimanere senza guida diventa così da un lato uno dei più grandi rischi di interrompere la pratica e dall'altro uno dei più grandi sproni a fare di tutto perché questo fatto possa il propulsore per fare i propri click e perché la strada prosegua... spesso per sé ed anche per i propri compagni che hanno meno volontà di noi.
D'altronde tutti concordano nel voler onorare gli insegnamenti (anche la memoria, nel caso di chi è scomparso) del proprio Maestro, ma pochi sono quelli disposti a tirarsi su le maniche e comprendere come sia possibile farlo nel CONCRETO: questi pochi rappresentano appunto il baluardo che ha fatto forse andare avanti fino ad ora la nostra disciplina... nonostante ogni evento nefasto che ha interessato i nostri Dojo e tatami.Si tratta di una grande crisi, che come tale, offre sempre enormi possibilità di evoluzione, oltre che di smarrimento: l'Aikido per me è proprio LA disciplina che insegna ad evolvere GRAZIE al conflitto... quindi la dinamica che ho esaminato con voi quest'oggi mi pare veramente "Aikidoistica" in tutti i sensi.Se vi accadrà di vivere questa crisi o qualcosa di simile, iniziate a non fasciarvi la testa per via di quanto complesso possa sembrare uscirne a testa alta: le azioni piccole e costanti sono quelle che - alla lunga - fanno la differenza.
E soprattutto, chiedetevi: "Chi voglio essere io... quello che di fronte ad una difficoltà si abbatte e rinuncia? Come intendo dimostrarmi quanto ci tengo? Cosa è prioritario per me?"
Detto questo, ricordiamoci delle frase (di Fabio Ramazzin Sensei) che spesso leggete in queste pagine:"Chi cerca una scusa, va a finire che la trova.... chi cerca una soluzione, va a finire che la trova".
Marco Rubatto